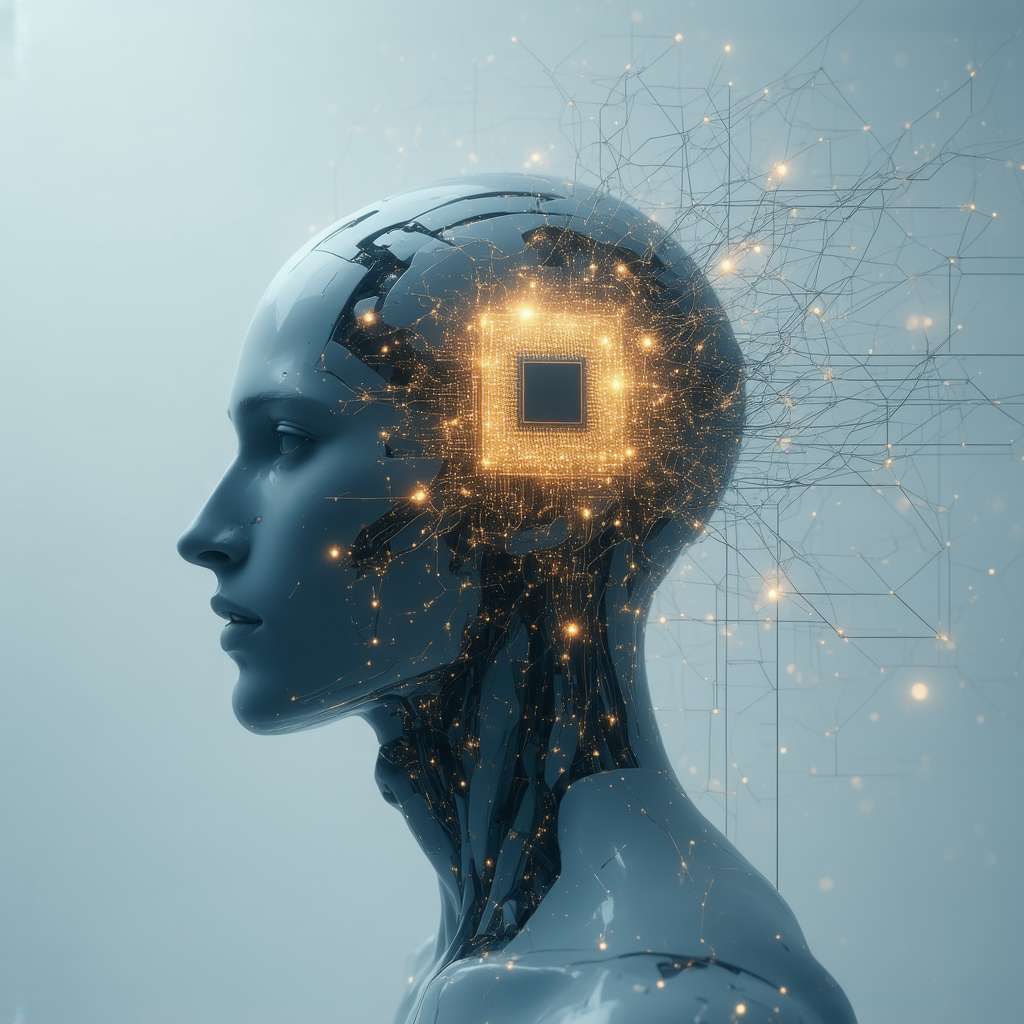- AI Mode: Google offre risposte elaborate, riducendo i clic.
- Calo del 35% nel CTR sui risultati di ricerca.
- Editori contro Google: sfruttamento dei contenuti senza compenso.
- Rischio di compromettere il concetto di autorialità e copyright.
- AI Overview offre link di approfondimento: nuove opportunità.
Il fulcro della discussione è l’evoluzione della ricerca web, in particolare l’integrazione sempre più marcata dell’intelligenza artificiale (AI) nei motori di ricerca. L’annuncio di Google sull’introduzione di AI Mode ha catalizzato questo dibattito. Questa funzionalità avanzata, a differenza dei tradizionali risultati di ricerca (SERP), offre risposte elaborate dall’AI, potenzialmente riducendo la necessità di cliccare sui siti web elencati.
L’introduzione di AI Overview in primavera aveva già anticipato questa tendenza, con analisti SEO che segnalavano un calo del traffico organico verso i siti web. AI Overview inserisce una “zona Google above the fold” contenente risposte articolate alle query, diminuendo i clic sui risultati di ricerca tradizionali. Con AI Mode, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, questa situazione potrebbe intensificarsi. Si tratta di una vera e propria chatbox che elabora risposte e consente un’analisi più approfondita, simulando una conversazione tra uomo e macchina. Strumenti come ChatGPT e DeepSeek hanno già eroso quote di mercato dei motori di ricerca tradizionali. La differenza cruciale è che il motore di ricerca stesso diventa l’AI, eliminando la separazione tra le due entità. Un esempio simile è Perplexity, ma con la potenza di Google e dei suoi milioni di utenti quotidiani.
Per le aziende che dipendono dalla visibilità sui motori di ricerca, le conseguenze economiche potrebbero essere significative. Questo include sia le aziende che attraggono clienti tramite la ricerca, sia i portali web che generano contenuti testuali e guadagnano tramite la pubblicità. Un calo delle visite si tradurrebbe in una diminuzione degli introiti pubblicitari. Da qui nasce lo scontro tra gli editori e Google.
La Reazione degli Editori e le Questioni di Copyright
Gli editori, rappresentati dalla News/Media Alliance, accusano Google di sfruttare i loro contenuti senza offrire una contropartita adeguata. Google ha sempre scansionato liberamente i testi dei siti web per indicizzarli e mostrarli nei risultati di ricerca. Questo sistema beneficiava sia Google, che aveva un web da scansionare, sia i siti web, che aumentavano la loro visibilità e il traffico. AI Overview e AI Mode mettono in discussione questo paradigma, spingendo gli editori a considerare la possibilità di proibire la scansione dei loro contenuti, privando le AI di dati e informazioni senza la visibilità online come compensazione. Le rassicurazioni di Google sulla presenza di un singolo risultato in alto non placano le preoccupazioni, dato il calo globale degli accessi ai siti web. Si stanno quindi valutando modalità alternative per attrarre utenti, bypassando Google.
Questo scenario solleva interrogativi sui diritti d’autore. Se le AI possono elaborare informazioni senza citare la fonte, il concetto di autorialità e copyright potrebbe essere compromesso. Si potrebbe quindi obbligare le AI a citare le fonti o vietare la scansione dei testi tramite firewall o configurazioni tecniche specifiche (file robots.txt). Mentre alcuni rischi sono già evidenti, con un calo di circa il 35% nel CTR sui risultati di ricerca, è importante ricordare che ogni trasformazione profonda porta con sé opportunità.
Nonostante le incertezze sull’AI Mode, l’AI Overview offre link di approfondimento. Come è possibile apparire tra le fonti citate da AI Overview? È possibile recuperare parte del CTR perso tramite questi link? Come misurarlo con strumenti di web analytics? Non ci sono certezze, ma è possibile delineare linee guida e identificare i fattori chiave per raggiungere questo obiettivo. È fondamentale puntare su contenuti approfonditi che scandaglino il tema trattato, rispondendo a domande precise. Questo approccio non differisce molto dalle tecniche di SEO copywriting, che si basano sulla qualità del testo e sulla completezza dell’informazione, arricchite dal ragionamento umano e dalle competenze specifiche. Le intelligenze artificiali, pur essendo artificiali, necessitano del ragionamento umano per funzionare efficacemente.
- 🚀 L'AI di Google è una rivoluzione o una minaccia...?...
- 📉 Calo del traffico web? Colpa dell'AI? Forse è ora di......
- 🤔 Ma l'AI capisce davvero qualcosa, o è solo una scimmia......
Intelligenza Artificiale e la Manipolazione del Pensiero
L’intelligenza artificiale nasce dalla convergenza di diverse prospettive rivoluzionarie, tra cui la teoria dei sistemi, la cibernetica, la teoria della computazione e il funzionalismo. La teoria dei sistemi descrive entità come cellule, organismi o nazioni come macchine complesse, separate dall’ambiente esterno da un confine semipermeabile. La cibernetica introduce l’idea di un sottosistema di controllo che supervisiona e regola il funzionamento complessivo del sistema. La teoria della computazione suggerisce che sia possibile automatizzare una sequenza di operazioni tramite un algoritmo. Infine, il funzionalismo postula che le azioni di un sistema possano essere descritte attraverso le funzioni che esso assolve, a prescindere dalla sua composizione materiale.
Negli anni ’50, queste prospettive si fusero nell’intelligenza artificiale, nella psicologia cognitiva e in altre discipline, dando origine alle scienze cognitive. Il postulato di base è che il pensiero consista nella manipolazione di configurazioni interne del sistema ad opera di un algoritmo. La mente sarebbe il sistema di controllo automatico dell’organismo, sostituendo concetti come coscienza e anima con algoritmi autosufficienti. Questo postulato, tuttavia, è una posizione di principio indimostrata, che può rivelarsi problematica o errata. Se l’intelletto è assimilabile a un programma per computer, allora per analogia un programma informatico è un intelletto, o quantomeno può diventarlo se adeguatamente strutturato. L’automazione di questi processi potrebbe essere vista come il culmine di una lunga tradizione del pensiero occidentale, oppure come una sua profonda distorsione.
Negli anni ’60 e ’70, questo programma di ricerca si espanse in vari ambiti, con obiezioni incentrate su ciò che si presumeva un computer non sarebbe mai stato in grado di fare, come giocare a scacchi o superare il test di Turing. L’intelligenza, in questa prospettiva, consiste nel fare cose, sollevando questioni teoriche e tecniche. Alan Turing suggerì che una macchina potesse essere considerata intelligente al pari di un essere umano qualora il suo comportamento fosse indistinguibile da quello umano. Questo implica che le proprietà distintive dell’individuo, come la soggettività e la consapevolezza, non influenzino il comportamento e pertanto non abbiano alcuna rilevanza. Il criterio proposto è che un sistema artificiale sia reputato intelligente quanto un umano se non se ne può discernere il comportamento. Se ricevono lo stesso input e producono il medesimo output, ciò che accade a livello materiale all’interno dell’uno e dell’altro è di secondaria importanza, così come è irrilevante che il primo contenga hardware e il secondo un sistema nervoso o “wetware”.

Oltre la Sconfitta: La Coscienza e l’Essere Umano
Nel 1997, il programma Deep Blue dell’IBM sconfisse il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov. Tuttavia, la macchina funziona in modo diverso dall’umano, basandosi sulla potenza computazionale piuttosto che sul riutilizzo creativo di spezzoni di partita memorizzati. Soprattutto, Kasparov sa di essere impegnato nel torneo, mentre la macchina non sa niente di tutto questo. La pratica degli scacchi costituisce solo una frazione della vita di Kasparov, la cui esistenza si dipana in un ambito cosciente ed estraneo al gioco. Diversamente dal computer, Kasparov prova soddisfazione per la vittoria e dispiacere per la sconfitta; inoltre, ride, mangia, legge libri, dialoga con gli altri, va al cinema, è stato sposato tre volte con due figli, è attivo in politica, si ammala, e così via. E ognuna di queste sfaccettature della sua vita si intreccia con le altre: Kasparov probabilmente non sarebbe diventato campione in un contesto familiare, sociale o culturale differente, forse gli capita di pensare al suo giardino durante una partita, forse non avrebbe dibattuto di AI se non avesse perso la sfida, e così via. Quale significato e utilità ha, dunque, la sconfitta di un essere umano da parte di un sistema artificiale, se in quest’ultimo manca qualsiasi consapevolezza del concetto di torneo, vittoria o sconfitta? Se non c’è nessuno “in casa”? Contro chi sta giocando Kasparov, e in che senso preciso subisce una sconfitta se manca un vincitore?
La lettura prevalente dell’episodio appare sensata solo se ci si concentra sulla prestazione scacchistica, trascurando l’essere umano che Kasparov incarna e che la macchina non è. Decidere di valorizzare la produzione piuttosto che l’essere umano è una scelta tutt’altro che imparziale. Essa implica la reificazione degli individui, ma non di tutti: solo di quelli che non hanno la possibilità di definire i termini della propria esistenza e del proprio valore. Coloro che si autoproclamano semidei e che progettano la “megamacchina”, stabilendo i criteri per confrontare il valore di umani e macchine, preservano, o si illudono di preservare, un’esistenza e un valore in prima persona, indipendenti dalla produttività o da qualsiasi altra considerazione che non sia il potere. È proprio su questi temi che si fonda la critica radicale al progetto dell’AI.
John Searle ha presentato due argomenti fondamentali: l’esperimento mentale della stanza cinese, che dimostra l’incapacità della sintassi di veicolare la semantica, e la tesi che l’algoritmo esiste solo nella percezione di un osservatore dotato di coscienza. La mente è consapevolezza, soggettività, presenza; e al suo interno può avvalersi di numerosi strumenti, tra cui, una volta appresi, il calcolo matematico o logico. Nel computer, una simile soggettività non esiste: vi è solo materia, organizzata e funzionante secondo le sue leggi, ma il calcolo è uno strumento della mente e non una caratteristica intrinseca della materia. L’idea, presuntamente scientifica, che nei circuiti del computer vi sia un ente che calcola è una forma di animismo, non dissimile dai culti Cargo melanesiani o dallo stupore di un bambino di fronte a un trenino elettrico in movimento.
Verso un Futuro Consapevole: Umanesimo Digitale
In definitiva, la questione centrale non è se l’AI possa replicare l’intelligenza umana, ma piuttosto come possiamo utilizzare questa tecnologia in modo etico e responsabile. Dobbiamo assicurarci che l’AI sia uno strumento al servizio dell’umanità, e non viceversa. Questo richiede una riflessione profonda sui valori che vogliamo preservare e promuovere in un mondo sempre più digitalizzato. La sfida è quella di integrare l’AI nelle nostre vite senza sacrificare la nostra umanità, la nostra creatività e la nostra capacità di pensiero critico.
Amici lettori, spero che questo articolo vi abbia offerto una prospettiva più chiara e approfondita sul tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sul mondo digitale. Per quanto riguarda la SEO, è fondamentale comprendere come i motori di ricerca utilizzano l’AI per valutare e classificare i contenuti. Una nozione base di SEO è l’importanza delle parole chiave: utilizzare termini pertinenti e specifici aiuta i motori di ricerca a comprendere di cosa tratta il tuo contenuto e a mostrarlo agli utenti interessati. Una nozione di SEO avanzata è l’analisi semantica: non basta utilizzare le parole chiave, ma è necessario creare contenuti che rispondano alle intenzioni di ricerca degli utenti, offrendo informazioni complete e di valore. Riflettete su come potete adattare le vostre strategie di contenuto per soddisfare le esigenze dei motori di ricerca basati sull’AI, senza però perdere di vista l’importanza di creare contenuti originali e di alta qualità che coinvolgano il vostro pubblico. La vera sfida è trovare un equilibrio tra l’ottimizzazione per i motori di ricerca e la creazione di contenuti che siano realmente utili e interessanti per le persone.